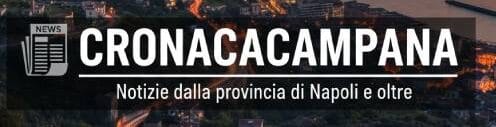Il vino analcolico rappresenta l’ultima frontiera del beverage, capace di unire tradizione enologica e innovazione tecnologica. Dopo il caffè senza caffeina e il latte senza lattosio, il mondo delle bevande accoglie un prodotto che mantiene il carattere del vino privandolo del suo componente più distintivo: l’alcool.
Per la normativa italiana, si definisce analcolico un vino con contenuto alcolico inferiore allo 0,5% volume, una soglia che lo distingue dai vini a basso tenore alcolico e da quelli tradizionali.
La dealcolazione – il processo di rimozione dell’alcol – può avvenire in diverse fasi produttive e attraverso molteplici metodologie, ciascuna con specifici effetti sul profilo organolettico finale.
Questa trasformazione risponde a esigenze di consumo sempre più diversificate, dove salute, benessere e sobrietà si integrano con il piacere della degustazione.
Cosa definisce il vino analcolico e come si classificano i vini dealcolati
Il vino analcolico nasce come un vino tradizionale, per poi subire processi che ne riducono o eliminano la componente alcolica. La legge italiana stabilisce parametri precisi: solo i prodotti con contenuto alcolico inferiore allo 0,5% volume possono fregiarsi della dicitura “analcolico”.
Esistono poi categorie intermedie di vini a contenuto alcolico ridotto, che si collocano tra questa tipologia e i vini convenzionali. È importante sottolineare che la stessa suddivisione non vale negli altri paesi del mondo, dove i limiti legali possono variare significativamente.
Il processo di dealcolazione può essere totale o parziale, ma in ogni caso il sapore del vino non resta esattamente inalterato. Possono verificarsi lievi differenze di colore o la perdita di alcuni composti aromatici volatili che contribuiscono all’odore complessivo.
L’azione “correttiva” sul vino, simile a quanto avviene per la birra analcolica, può tecnicamente avvenire prima, dopo o durante la fermentazione.
Limitare la produzione di alcol prima della fermentazione del vino
Il primo approccio alla produzione di vino analcolico agisce sulla materia prima, intervenendo per limitare la formazione di alcol già in vigna. Ciò che rende alcolico il vino è l’etanolo, che si forma quando gli zuccheri contenuti nell’uva si trasformano in alcol e anidride carbonica grazie all’azione degli enzimi del lievito. Meno zuccheri sono presenti all’inizio, meno alcol si produrrà.
I viticoltori possono gestire la concentrazione zuccherina dell’uva modificando il rapporto tra l’area della foglia e il frutto. Un metodo prevede di raccogliere l’uva in ritardo o in anticipo rispetto alla tradizione e di applicare specifiche tecniche di potatura in determinati periodi, ottenendo così un’uva meno zuccherina e destinata a diventare meno alcolica.
Altre strategie applicabili in cantiera includono:
Allungare il mosto con acqua per diluire la concentrazione di zuccheri.
Filtrare il succo d’uva pigiato attraverso filtri a membrana che selezionano le molecole, bloccando parte degli zuccheri.
Aggiungere un enzima specifico, la glucosio ossidasi, che riduce il glucosio presente nel mosto ancor prima che abbia inizio la fermentazione. In tutti i casi, il principio è identico: meno zuccheri significherà meno alcol.
Piano B: agire sulla fase di fermentazione del mosto
La fermentazione è la fase cruciale in cui gli zuccheri del mosto si trasformano in alcol. Anche in questo passaggio è possibile intervenire per limitare la produzione di etanolo. Il mosto, ottenuto dalla spremitura dei chicchi d’uva, viene inoculato con i lieviti che danno il via al processo biochimico.
Una strategia consiste nell’utilizzare lieviti diversi dai classici Saccharomyces. Alcuni ceppi, infatti, fermentano naturalmente meno zuccheri, convertendone una percentuale minore in alcol. In alternativa, si può ricorrere a lieviti modificati in laboratorio tramite alterazione genetica, progettati per “funzionare di meno” e produrre quindi meno etanolo.
Un altro metodo efficace è la fermentazione arrestata: il processo viene interrotto deliberatamente prima del suo compimento totale. Bloccando prematuramente l’attività dei lieviti, si dà poco tempo all’alcol per formarsi, lasciando nel prodotto finale una quantità residua di zuccheri non fermentati e un tenore alcolico molto contenuto.
Togliere l’etanolo dal vino dopo la sua formazione
I metodi più diffusi e tecnologicamente avanzati per produrre vino analcolico agiscono dopo che la fermentazione è avvenuta e l’alcol si è già formato. Queste tecniche di dealcolazione post-fermentazione sono spesso ritenute le più efficaci nel preservare il profilo aromatico del vino originale. Si basano su processi di filtraggio a membrana che sfruttano pori di dimensioni infinitesimali per separare selettivamente le molecole.
Uno dei processi più noti è l’osmosi inversa. In condizioni normali, in osmosi, il solvente si muove da una soluzione meno concentrata a una più concentrata. Applicando una pressione specifica e controllata, si innesca invece il processo inverso: il solvente migra dalla soluzione più concentrata a quella meno concentrata. In pratica, il vino viene fatto circolare controcorrente all’acqua, separati da una membrana a fibra cava idrofobica.
La pressione applicata fa evaporare l’etanolo, il cui vapore fuoriesce dai pori della membrana per condensarsi poi nell’acqua. Questo metodo, che avviene a temperature non eccessive, lascia quasi inalterati i composti aromatici del vino.
Un altro sistema molto efficace è quello della colonna a cono rotante, che opera a basse temperature e pressioni. Il vino viene fatto passare in una macchina dotata di coni verticali rotanti. La rotazione distribuisce il vino in strati sottilissimi sulla superficie dei coni, massimizzando l’area di contatto e favorendo l’evaporazione delle molecole di etanolo. Il vantaggio distintivo di questa tecnologia sta nel fatto che gli aromi del vino vengono recuperati separatamente dall’etanolo e possono quindi essere reintegrati nel vino dealcolato finale, preservandone al massimo il carattere organolettico.
Viaggio tra osmosi inversa e fermentazione controllata
Tutti i metodi di dealcolazione illustrati alterano in qualche misura il sapore del vino, poiché la presenza o assenza di alcol influisce direttamente sulla percezione di corpo, struttura e aromi. Tuttavia, è un dato di fatto che la dealcolazione post-fermentazione, e in particolare l’osmosi inversa e la colonna a cono rotante, riesce a mantenere meglio il sapore del vino originale. Per questa ragione, sono i processi più usati e apprezzati dall’industria enologica per la produzione di vini analcolici di qualità, capaci di avvicinarsi all’esperienza di degustazione del vino tradizionale.