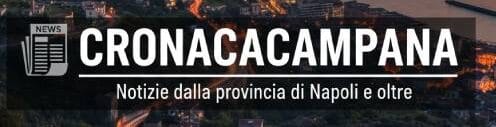Un volto gigante osserva chiunque percorra un vicolo dei Quartieri Spagnoli. I suoi lineamenti sono familiari a tutti, un’icona del calcio che ha cambiato per sempre la storia di una città. Questo non è un semplice dipinto su un muro. È un santuario laico, una tappa obbligata in un pellegrinaggio moderno che unisce tifosi, turisti e campioni.
Il murales di Diego Armando Maradona a Napoli trascende l’arte urbana per diventare il cuore pulsante di un culto inestinguibile. La sua storia, fatta di gloria, oblio e rinascita, riflette perfettamente l’amore viscerale e complesso tra il calciatore e la sua città adottiva.
L’origine: un’opera nata dalla passione popolare
L’opera nacque nel 1990, subito dopo la vittoria del secondo scudetto del Napoli. L’autore, Mario Filardi, decise di omaggiare l’idolo con un ritratto sulla facciata di un palazzo in via Emanuele de Deo. L’impresa fu un’operazione collettiva e quasi clandestina.
Filardi completò il lavoro in due notti e tre giorni, utilizzando una piccola fotografia come modello. Per finanziare i materiali, gli ultras del Napoli organizzarono una colletta. Di notte, per illuminare la parete, i tifosi accendevano i fari delle loro automobili, creando un palcoscenico di fortuna per l’artista.
L’inaugurazione fu un evento di quartiere, una grande festa per celebrare Maradona e un trionfo che sembrava destinato a durare in eterno.
Il declino e la rinascita: un simbolo che non poteva morire
Il destino del Napoli e quello del murales seguirono lo stesso percorso. Con il declino sportivo della squadra e il fallimento societario del 2004, anche l’opera di Filardi cadde nell’oblio. I colori si sbiadirono sotto il sole e le intemperie. Un evento ne compromise definitivamente l’integrità.
Nel 1998, l’apertura di una persiana, posizionata proprio all’altezza del volto, rovinò il dipinto. Per molti anni, il murales rimase una reliquia sbiadita, un ricordo di giorni migliori. La rinascita avvenne nel 2016 e nel 2017, grazie a due interventi di restauro curati da Salvatore Iodice e Francisco Bosoletti.
Quest’ultimo, in particolare, ridisegnò completamente il volto di Maradona, restituendo alla città il suo simbolo.
La trasformazione in luogo di culto
Il 25 novembre 2020, la notizia della morte di Maradona sconvolse il mondo. In quel momento, il murales nei Quartieri Spagnoli assunse un nuovo e potente significato. Divenne il luogo di ritrovo spontaneo per migliaia di persone in lutto.
Da quel giorno, si trasformò nel luogo di pellegrinaggio così come lo conosciamo oggi. Il flusso di visitatori divenne costante. Stime non ufficiali riportano un transito di circa sei milioni di persone ogni anno in quella stretta via. La vittoria dello scudetto nel 2022 e nel 2024 non fecero che alimentare ulteriormente l’aura mistica del posto, trasformando ogni visita in un atto di ringraziamento.
Un pellegrinaggio universale
Il fascino del murales non conosce confini. Non sono solo i tifosi del Napoli a visitarlo. Anche le squadre avversarie, in città per le partite in trasferta, compiono lo stesso rito. Anche i giocatori e gli allenatori del club cercano il momento giusto per un incontro privato con l’immagine di Diego.
L’attuale allenatore del Napoli, Antonio Conte, lo visitò in piena notte con la sua famiglia. Anche il campione georgiano Kvicha Kvaratskhelia si recò in pellegrinaggio per un ultimo saluto prima del suo trasferimento. Questi gesti dimostrano che quel murales è un simbolo di Napoli nel mondo.
Racconta, meglio di qualsiasi discorso, il rapporto inscindibile tra Maradona, la città e la sua squadra. È un’opera d’arte viva, che respira con la fede di chi la guarda.