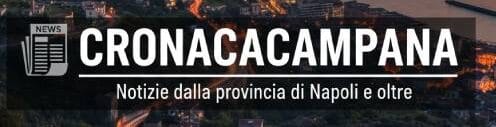L’archivio ufficiale del Premio Nobel per la Pace custodisce un documento sconcertante. Nel gennaio del 1939, mentre l’Europa scivolava verso l’abisso, il nome di Adolf Hitler figurava tra i candidati per il massimo riconoscimento dedicato alla pacificazione tra le nazioni. Questa nomina, apparentemente assurda, non fu un errore ma una calcolata e sarcastica protesta politica. Un gesto estremo destinato a smascherare, con amara ironia, le contraddizioni e le complicità di un’epoca.
Il contesto: un’Europa sull’orlo del conflitto
All’alba del 1939, il continente respirava una pace fragile e illusoria. Gli accordi di Monaco, siglati pochi mesi prima nel settembre 1938, avevano consegnato i territori dei Sudeti alla Germania nazista, alimentando la pericolosa convinzione che si potesse placare l’espansionismo hitleriano attraverso concessioni.
In quel clima di apprensione, diverse personalità politiche e accademiche proposero il nome del primo ministro britannico Neville Chamberlain per il Nobel per la Pace 1939, considerandolo l’artefice di quel precario equilibrio.
Una nomination come atto di protesta
Fu in questo scenario teso che un parlamentare svedese, il socialdemocratico Erik Gottfrid Christian Brandt, decise di agire. Noto per le sue posizioni antifasciste, Brandt inviò una lettera al Comitato norvegese per il Nobel.
In essa, propose formalmente la candidatura di Adolf Hitler. Il gesto, registrato il 27 gennaio 1939, non nasceva da una reale ammirazione. Era, al contrario, una feroce critica alla politica di appeasement perseguita da Chamberlain e da altri leader europei. Brandt voleva dimostrare, in modo plateale, l’assurdità di premiare una pace fondata sulla resa alla prepotenza.
Lo scandalo e il ritiro immediato
La notizia della candidatura di Hitler si diffuse rapidamente, suscitando un’ondata di sdegno in Svezia e oltre. L’intento satirico di Brandt non fu immediatamente compreso dal pubblico e dalle istituzioni.
Di fronte al dilagare delle polemiche, il parlamentare svedese fu costretto a ritirare la propria proposta pochi giorni dopo, il 1° febbraio 1939. In una lettera di ritiro, Brandt cercò di chiarire le sue reali intenzioni. Spiegò che il suo era un atto simbolico per denunciare la miopia di chi, in nome della pace, stava di fatto legittimando il regime nazista.
Uno specchio delle contraddizioni del Nobel
La vicenda della candidatura di Hitler non è un caso isolato nella storia del Premio Nobel per la Pace. Questo episodio estremo funge da potente riflesso delle tensioni politiche del suo tempo. Il premio, per sua natura, spesso interseca le delicate dinamiche della diplomazia internazionale, a volte con esiti controversi.
Nel 1973, per esempio, il rivoluzionario vietnamita Le Duc Tho rifiutò il riconoscimento, condiviso con Henry Kissinger, sostenendo che una pace reale in Vietnam non era ancora stata raggiunta. Un monito che la storia successiva si incaricò di confermare.
La pace oggi: un obiettivo sempre più complesso
Il mondo contemporaneo continua a lottare per il raggiungimento di una pace stabile. Secondo i dati dell’Uppsala Conflict Data Program, nel 2024 il numero di conflitti armati tra stati ha raggiunto il picco più alto dal 1946.
Il Peace Research Institute Oslo (PRIO) e la Geneva Academy monitorano decine di crisi attive, da quelle in Ucraina e nel Medio Oriente alle complesse guerre ibride che affliggono regioni come il Sahel e il Corno d’Africa. La mappa della violenza globale appare più frammentata e intricata che mai.
Il Nobel per la Pace 2025 tra segreti e indiscrezioni
Chi saranno i candidati per il Nobel per la Pace 2025? La Fondazione Nobel mantiene un rigoroso segreto sulle nomination per cinquant’anni. Sappiamo ufficialmente che per il 2025 sono state presentate 338 candidature, tra individui e organizzazioni.
Tuttavia, alcune voci circolano. Secondo l’agenzia Reuters, il governo cambogiano avrebbe proposto la candidatura di Donald Trump, riconoscendone un presunto contributo al dialogo internazionale. Altri osservatori ipotizzano una candidatura per Alexei Gorinov, attivista russo detenuto per aver criticato la guerra in Ucraina.
Il difficile compito di riconoscere la pace
Asle Sveen, storico del premio Nobel, ha spiegato la difficoltà intrinseca di questo riconoscimento. “È sempre rischioso promuovere qualcuno. Non si è in grado di prevedere cosa può accadere in futuro”.
Questa imprevedibilità rende il Nobel per la Pace profondamente diverso dagli altri premi. La storia è costellata di omissioni emblematiche, la più celebre delle quali riguarda Mohandas Karamchand Gandhi.
Il profeta della nonviolenza fu candidato più volte ma non vinse mai. La sua assenza rimane, come ammesso dallo stesso Comitato Nobel, la più grande lacuna nell’albo d’oro.
La vicenda della candidatura di Hitler, così come le omissioni e le controversie che ne sono seguite, ci ricordano che il premio non è solo un riconoscimento, ma un termometro delle inquietudini globali e del nostro perpetuo, difficile cammino verso la pace.