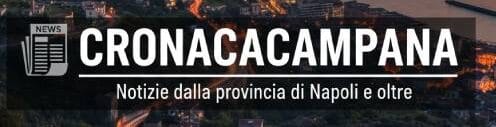Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025, l’area dei Campi Flegrei ha vissuto un’ora di lieve agitazione sismica. Una scossa principale di magnitudo 3.3, avvertita distintamente dalla popolazione, ha dato il via a uno sciame sismico conclusosi con tredici eventi in totale. L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha prontamente monitorato la sequenza e comunicato ai Comuni interessati la fine dell’episodio.
Questo evento non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di unrest che da mesi interessa questa caldera, una delle più pericolose al mondo per l’alta densità abitativa. Capire cosa significhino questi terremoti non è solo una questione scientifica, ma un’esigenza di sicurezza per centinaia di migliaia di persone.
Una notte di lievi scosse: i dati del sisma
Nella tarda serata di sabato 4 ottobre, precisamente alle 19:59 UTC (le 21:59 locali), ha avuto inizio lo sciame sismico nell’area flegrea. L’evento più significativo, quello di magnitudo 3.3, si è verificato alle 00:50 ora locale del 5 ottobre.
L’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 4 km a sud-ovest di Pozzuoli, a una profondità molto superficiale di soli 2.4 km. La superficialità dell’ipocentro spiega perché la scossa, sebbene di magnitudo moderata, sia stata avvertita così chiaramente in un’area così vasta.
Lo sciame è proseguito con altre scosse di minore intensità, tra cui una di magnitudo 1.9 registrata poco dopo la mezzanotte. In via preliminare, l’INGV ha localizzato dodici dei tredici eventi che hanno composto la sequenza.
La scossa principale è stata percepita come una leggera vibrazione in diverse località, tra cui Bagnoli, Pozzuoli, Pianura, Fuorigrotta e Quarto, arrivando fino a Napoli, distante 12 km dall’epicentro. Per fortuna, data la magnitudo contenuta, il terremoto non ha causato danni significativi, ma ha senza dubbio riacceso l’attenzione sul fenomeno del bradisismo che interessa l’area.
Il contesto: bradisismo in corso
Il terremoto di stanotte non è un evento eccezionale, ma parte di un trend. I Campi Flegrei stanno attraversando una fase di unrest che dura da decenni, caratterizzata da un progressivo sollevamento del suolo (bradisismo) e da un aumento della sismicità.
Dal 2005 a oggi, il suolo a Pozzuoli si è sollevato di circa 1.4 metri. Questo sollevamento esercita una pressione crescente sulle rocce superficiali, che reagiscono fratturandosi e generando terremoti molto superficiali, come quello di magnitudo 3.3 di questa notte.
L’attività sismica nell’area è significativamente aumentata. Solo nell’ultima settimana, la zona dei Campi Flegrei ha registrato ben 184 terremoti, con magnitudini per lo più inferiori a 2.0, ma con un picco proprio nella scossa di magnitudo 3.3 di questa notte.
Questo dato fornisce la misura di un’attività incessante e a volte intensa. Recentemente, il 13 marzo 2025, la zona è stata addirittura scossa da un terremoto di magnitudo 4.6, il più forte mai registrato nella regione. Il quadro che emerge è quello di un sistema vulcanico in costante e crescente pressione.
La risposta scientifica: il monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano
L’Osservatorio Vesuviano (OV) dell’INGV è l’istituzione che, con competenza e autorevolezza, vigila costantemente sull’evoluzione della situazione. È stato l’OV a comunicare ufficialmente all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli l’inizio e la conclusione dello sciame sismico, applicando criteri precisi e consolidati per la definizione di questi eventi. Questo dialogo costante tra scienza e istituzioni è fondamentale per la gestione del rischio e la protezione dei cittadini.
Le reti di monitoraggio dell’OV sono state in grado di localizzare con precisione la sequenza, fornendo dati essenziali in tempo reale. Le tecniche di sorveglianza si stanno evolvendo. Uno studio recente, condotto in collaborazione tra INGV, Università di Pisa e GFZ di Potsdam, ha utilizzato tecniche sismologiche avanzate per analizzare i terremoti degli ultimi dieci anni.
La ricerca ha scoperto per la prima volta segnali risonanti di lunghissimo periodo, interpretati come l’oscillazione di strutture simili a fratture riempite di fluidi. La stabilità di questi segnali negli anni suggerisce che, nonostante la forte pressione, il sistema non mostra al momento segni di un’imminente eruzione.
Una nuova era per la comprensione del rischio: il ruolo dell’IA
La comprensione scientifica dei Campi Flegrei sta facendo un balzo in avanti grazie all’intelligenza artificiale. Un team di ricerca di Stanford, in collaborazione con l’INGV, ha recentemente sviluppato un modello di AI in grado di rilevare molti più terremoti di quanto fosse possibile in passato. Applicando questo strumento ai dati sismici dal 2022 al 2025, il numero di terremoti identificati nell’area è passato da circa 12.000 a oltre 54.000.
Questa mole di dati senza precedenti ha permesso di individuare con chiarezza strutture tettoniche prima nascoste, come due faglie che convergono sotto la città di Pozzuoli. Questa scoperta è cruciale per la valutazione del rischio sismico.
Gli esperti sottolineano come “queste lunghe faglie suggeriscono che un terremoto di magnitudo 5 non sia da escludere”. L’AI non solo migliora la nostra conoscenza, ma fornisce uno strumento operativo all’INGV per una risposta più rapida e informata ai cambiamenti del sistema vulcanico.
Cosa ci aspetta? Tra eruzioni e terremoti
Quando si parla di Campi Flegrei, il pensiero corre inevitabilmente al rischio di un’eruzione. Tuttavia, molti esperti concordano che, nel breve termine, la minaccia principale potrebbe non essere un’eruzione, ma proprio un terremoto moderato ma superficiale, potenzialmente in grado di causare danni significativi in un’area così urbanizzata.
L’eruzione del 1538, l’unica storica dell’area, è spesso presa a modello per studiare come un periodo di unrest possa evolvere verso un evento eruttivo. I precursori di quell’eruzione includono decenni di sollevamento del suolo e intensa sismicità, un quadro che presenta alcune somiglianze con l’attuale.
La scienza, però, non è inerte. La sfida oggi è duplice: da un lato, comprendere i meccanismi profondi per valutare la possibilità di un’eruzione; dall’altro, gestire il quotidiano rischio sismico legato al sollevamento del suolo. I piani di protezione civile si basano proprio su questi scenari.
La storia ci insegna che l’area è soggetta a crisi cicliche, come quelle che portarono all’evacuazione di Pozzuoli nel 1970 e nel 1984. Oggi, strumenti più potenti e una conoscenza più approfondita ci permettono di affrontare l’incertezza con maggiore consapevolezza.
Vivere sulla caldera: una conclusione vigile
La notte del terremoto di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei è finita senza danni, ma ha lasciato una traccia nella comunità. È il promemoria di un territorio vivo e dinamico, che richiede rispetto, attenzione e una scienza solida. L’episodio non deve generare allarmismo, ma non può nemmeno essere ignorato. È un tassello in un puzzle più grande, che scienziati dell’Osservatorio Vesuviano e di tutto il mondo stanno pazientemente componendo.
La vera sicurezza per le centinaia di migliaia di persone che vivono sulla caldera passa attraverso il monitoraggio continuo, la ricerca innovativa e una comunicazione trasparente. La notte del 5 ottobre ci ricorda che la vigilanza è il prezzo da pagare per la convivenza con uno dei vulcani più affascinanti e complessi del pianeta.