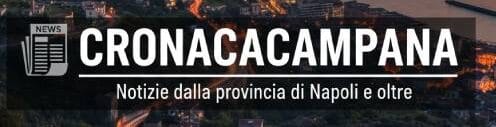Era una serata di dicembre come tante altre quando un Frecciarossa partito da Lecce e diretto a Venezia improvvisamente perse il suo regolare ritmo. Nei pressi di Faenza, il convoglio ad alta velocità iniziò a procedere a singhiozzo, accelerando e frenando in modo anomalo. Pochi minuti dopo, alle 19:52 del 10 dicembre 2023, l’inevitabile: l’urto contro un Intercity fermo sui binari. Il botto fu fortunatamente senza vittime, ma le conseguenze si estesero rapidamente come un’onda d’urto attraverso il sistema ferroviario nazionale.
Due ricoveri, sette accessi al pronto soccorso, una linea bloccata fino al giorno successivo, 31 treni in ritardo, tre cancellati e diciannove deviati: un caos che nascondeva un mistero. La domanda che tutti si ponevano era semplice: com’era potuto accadere? La risposta, emersa gradualmente dalle indagini, avrebbe rivelato una verità più inquietante del semplice errore umano.
Il sistema di sicurezza ignorato e il pedale “dimenticato”
La dinamica dell’incidente ruota attorno a sette minuti cruciali, durante i quali il sistema di sicurezza del treno rimase completamente ignorato. Per comprendere la gravità di quanto accaduto, è necessario spiegare un dispositivo fondamentale: il “pedale di vigilanza”, che il macchinista deve premere regolarmente per confermare al sistema di essere cosciente e attento alla guida. Dalle 19.45 alle 19.52 di quella sera, quel pedale non venne premuto .
Nel frattempo, il treno manifestava chiari segni di una guida anomala. Il sistema, rilevando l’inattività del macchinista, aveva automaticamente ridotto la velocità a 80 km/h. Tuttavia, la locomotiva rimaneva impostata su 175 km/h, creando una pericolosa discrepanza tra i comandi automatici e le intenzioni presunte del guidatore.
Il macchinista non intervenne per correggere questa situazione. Il risultato fu un percorso a scatti, con otto successive, inspiegabili variazioni di velocità che precedettero l’impatto con l’Intercity fermo. Questa sequenza di eventi ha costituito il cuore dell’indagine, portando gli inquirenti a escludere malori o svenimenti e a concentrarsi su altre ipotesi.
La verità choc: la dipendenza e le accuse del macchinista
Le indagini successive all’incidente hanno portato alla luce una verità sconcertante. Gli esami tossicologici, effettuati sia sul sangue che sul capello del macchinista – un quarantenne veneziano – hanno accertato la positività alla cocaina. L’uomo non ha tentato di nascondere la propria situazione, ammettendo con gli investigatori di essere un consumatore abituale della sostanza e di esserne dipendente da circa un anno .
Ma è stata la successiva dichiarazione a gelare il sangue degli inquirenti e a trasformare un caso individuale in un potenziale scandalo sistemico. Il macchinista ha affermato: «Quanto all’uso o dipendenza da sostanze stupefacenti, si tratta di un caso non isolato tra i colleghi macchinisti e da sempre riscontrato dal datore di lavoro». In altre parole, secondo la sua testimonianza, non si trattava di un episodio isolato, ma di una pratica diffusa della quale le Ferrovie dello Stato sarebbero state a conoscenza.
Il suo legale, l’avvocato Leonello Azzarini, ha successivamente cercato di mettere un freno a queste dichiarazioni, precisando: «Lo ha detto lui, al momento non si sa nulla di altri macchinisti». Tuttavia, il dubbio era ormai gettato nell’opinione pubblica.
Le conseguenze legali e il nodo processuale
Il percorso giudiziario ha proceduto con esiti severi per il macchinista. Il 18 gennaio 2024, poco più di un mese dopo l’incidente, l’uomo è stato sospeso in via cautelare dal servizio. Successivamente, ha perso definitivamente il lavoro con Ferrovie dello Stato, con il giudice che ha confermato il licenziamento e lo ha condannato a pagare 2.850 euro per le spese processuali .
Tuttavia, l’uomo ha annunciato che intende fare appello, e qui si inserisce il nodo cruciale della vicenda legale. La difesa dovrà affrontare una questione probatoria fondamentale: come dimostrare che l’incidente sia stato causato specificamente dallo stato di alterazione da cocaina, e non da altre circostanze?
Il giudice ha infatti evidenziato che non esistono prove che il mancato utilizzo del pedale di vigilanza sia direttamente riconducibile all’assunzione di stupefacenti, pur in presenza della confermata positività. Questo aspetto costituirà probabilmente il terreno principale della battaglia in appello, con l’esito che potrebbe avere implicazioni significative per casi analoghi.
Oltre il singolo caso: riflessioni sulla sicurezza sistemica
La dichiarazione più sconvolgente del macchinista – «siamo in tanti e l’azienda lo sa» – solleva interrogativi che travalicano la responsabilità individuale, investendo il sistema di sicurezza nel suo complesso. Se le affermazioni dovessero trovare riscontro, ci troveremmo di fronte non solo a una serie di comportamenti individuali gravemente negligenti, ma a una potenziale falla sistemica nei controlli e nella prevenzione.
Il caso del Frecciarossa di Faenza impone una riflessione profonda sui protocolli di sicurezza e sui meccanismi di monitoraggio del personale addetto a servizi essenziali. I sistemi tecnologici di sicurezza, per quanto avanzati, rimangono efficaci solo se integrati con rigorosi controlli sulle condizioni psico-fisiche degli operatori. L’episodio dimostra come un singolo anello debole, soprattutto se inserito in un contesto di presunta tolleranza, possa innescare una reazione a catena dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche.
Conclusioni: un monito per il futuro
Quasi due anni dopo l’incidente, la vicenda giudiziaria è lungi dall’essersi conclusa, con l’appello del macchinista che promette di tenere viva l’attenzione sul caso. Al di là dell’esito processuale, ciò che rimane è un profondo interrogativo sulla trasparenza e sulla cultura della sicurezza. Le dichiarazioni choc del macchinista, seppur ancora da verificare compiutamente, suonano come un monito per l’intero sistema dei trasporti.
L’incidente di Faenza, nella sua drammaticità, ha evitato il peggio in termini di vite umane, ma ha messo in luce vulnerabilità potenzialmente letali. Serve ora una risposta chiara dalle istituzioni e dalle aziende coinvolte: controlli più stringenti, trasparenza assoluta e tolleranza zero verso comportamenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Solo così la lezione di quel dicembre 2023 non sarà stata appresa invano.